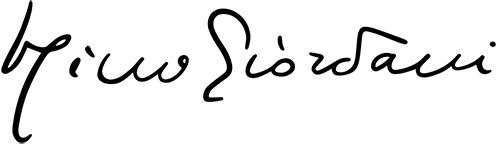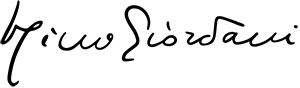Questa maledizione della guerra (seconda parte). La ferita al fronte
Per continuare a celebrare il centenario della prima guerra mondiale, vi proponiamo la seconda parte dell’esperienza di Igino Giordani sulla sua vita in trincea, di cui abbiamo pubblicato nei giorni scorsi la prima parte.
L’onore della dimostrazione toccò a me, perché ero l’ufficiale più giovane. Il capitano mi disse che il generale aveva designato la nostra compagnia, e il comandante della compagnia aveva designato il mio plotone.
Prima dell’alba i miei uomini – una ventina, ed io in testa – prendemmo ad arrampicarci verso i reticolati austriaci, traendoci dietro un tubo esplosivo, destinato a squarciare la ressa dei fili spinati. Ma dal nemico fummo subito avvistati e colpiti. In pochi minuti, quasi tutti i giovani furono o uccisi o feriti. Con l’aiuto d’un soldato (il mio attendente), riuscii a incastrare il tubo di gelatina dentro l’intrigo di fili di ferro, sopra la nostra testa. Bisognava ora farlo brillare. Mentre apprestavamo gli ordigni del caso, sentii un colpo (assai leggero, quasi un buffetto) sulla gamba destra, e subito dopo la vidi girare di forza propria e risalire a casaccio, da sé, come se non mi appartenesse. Alzai la mano destra per intervenire e scorsi le dita penzolanti che grondavano sangue. Ne argomentai che ero ferito.
Ma non sentivo dolore. L’attendente e un altro soldato mi vollero sottrarre alla sparatoria. Non era facile districarmi da quei rovi e quelle rocce. Nello sforzo che essi fecero – e lo facevano con amore –, mentre cominciava a venir fuori una sofferenza atroce dalla mia ferita e sgorgava sangue da più siti, l’attendente, chino sulla mia persona, fu colpito da un proiettile in fronte, donde fuoruscì uno spruzzo di cervello. Egli mi crollò addosso, cadavere massiccio. Cominciavo a perdere le forze e capii che, se non mi fossi sbrigato a rimuovere il cadavere di quella povera creatura, sarei rimasto immobilizzato in quel groviglio. E con uno sforzo del braccio sinistro riuscii delicatamente ad allontanarlo. L’altro soldato allora, su mio suggerimento, afferrò la mia gamba sinistra, che era sana, e mi rotolò giù per il pendio. Quando si trattò di scavalcare il bordo della trincea, il poveretto prese anche lui una fucilata. Alcuni soldati della trincea, che ci avevano scorti riuscirono ad acciuffarmi e gittarmi dentro: mucchio semicadaverico di stracci e sangue.
Pur così, mentre il tenente medico accorso mi prestava le prime cure, avvertii il senso orrido dell’accaduto; e, al sopraggiungere del capitano, gli feci rilevare, tra il silenzio stupefatto dei soldati, l’assurdità dell’ordine dato per cui un intero plotone era rimasto ferito o ucciso.
Il capitano generoso rispose facendo un elogio breve, ma denso del suo subordinato ferito; e diede ordine che fossi trasportato a un posto di cura. Per il contegno di quella operazione e per la mia condotta ordinaria in trincea, mi fece poi conferire la medaglia d’argento al valore militare.
Iniziai una marcia in barella, la quale doveva durare 24 ore. Il sangue, coagulandosi, m’incollò – ricordo – alla branda del vagone, nel treno che mi portò a Milano. Ciò che più mi colpì, arso com’ero dalla febbre, fu la massa di popolo che alla stazione attendeva i feriti accogliendoli con lagrime.
 Fui assegnato all’ospedale della Baggina. Capitai in un reparto assistito dal chirurgo Luigi Negri, una delle più grandi anime incontrate nella mia esistenza. Io ero sentimentalmente esuberante, ed egli era recettivo a tale esuberanza. Mi affidai a lui. E, con il suo incoraggiamento affrontai la cura, la quale durante tre anni d’ospedale e vari mesi fuori ospedale doveva sanarmi dalla frattura comminuta del femore destro e della mano destra. Il proiettile d’un «cecchino» aveva colpito l’osso della gamba e nell’urto era esploso, e aveva minutamente fratturato il femore per più di dieci centimetri. Un frammento della pallottola aveva colpito la mano destra.
Fui assegnato all’ospedale della Baggina. Capitai in un reparto assistito dal chirurgo Luigi Negri, una delle più grandi anime incontrate nella mia esistenza. Io ero sentimentalmente esuberante, ed egli era recettivo a tale esuberanza. Mi affidai a lui. E, con il suo incoraggiamento affrontai la cura, la quale durante tre anni d’ospedale e vari mesi fuori ospedale doveva sanarmi dalla frattura comminuta del femore destro e della mano destra. Il proiettile d’un «cecchino» aveva colpito l’osso della gamba e nell’urto era esploso, e aveva minutamente fratturato il femore per più di dieci centimetri. Un frammento della pallottola aveva colpito la mano destra.
Alla Baggina, s’iniziò la serie degl’interventi chirurgici. Nel primo, fui per morire asfissiato sotto la maschera: non s’era sviluppata allora la tecnica anestetica.
Mi aiutò, per mesi e mesi di sofferenza, la religione. Pregavo e nella preghiera attingevo una purezza dello spirito che contrastava con la flatulenza delle piaghe. Nella corsia c’erano degli ufficiali, che si lamentavano senza fine; altri, i più, resistevano con forza. Non pochi morivano. Qualche anno dopo, il prof. Negri, in una relazione scientifica, doveva asserire che, con le ferite del mio tipo, il 96 per cento morivano. Io sopravvissi, ma, col calar delle forze fisiche, in questi ultimi anni, la ferita ha acuito le mie sofferenze, e ha finito col togliermi la capacità di camminare. Guaio che si sarebbe evitato se a quell’epoca ci fosse stata una più adulta ortopedia.
Nella Baggina, a tutti i ricoverati della nostra corsia era di conforto l’assistenza d’una suora: suor Giuseppina, che sbocciava dalla porta lontana come un angelo quando più si soffriva: luminosa, ridava luce alle anime. Dopo qualche mese, la sostituirono con una consorella, nominata anch’essa Giuseppina: più raccolta, più timida, ma non meno amorevole. Ricordo che un ufficiale, piuttosto gradasso, le chiese:
– Ma come fa lei a rinunziare alle gioie dell’esistenza, in cambio di fantasmi?… E aggiunse una sequela di sofismi: i soliti. – Se io mi sono sbagliata – commentò la suora – mi sarò sbagliata per dieci, venti, trenta anni; ma se si sbaglia lei, si sarà sbagliato per l’eternità.
Una cosa che mi dava consolazione era il poter mandare ogni mese lo stipendio intero ai genitori: gustavo la gioia che ne provavano, essi, così poveri, a cui era mancato spesso il necessario. Ricordo un giorno della mia infanzia, in cui mamma non aveva preparato la modesta refezione del mezzodì perché non aveva un centesimo: la reazione di mio padre era stata magnifica: saltato via di casa aveva girato per il paese e gli era riuscito di raccogliere un’arca di viveri.
Il mio stipendio di ufficiale, doppio per i feriti come per i combattenti al fronte, doveva dare un po’ di pace a mamma e alle sorelle… Mio fratello Vincenzo, era stato chiamato sotto le armi e si preparava pure lui alla guerra.
E un giorno mamma e papà vennero a trovarmi. Era la prima volta che uscivano dalla loro provincia e facevano un viaggio così lungo. Ignoravano l’uso dell’albergo e dei treni stessi, sì che arrivati chiesero indicazioni nell’ospedale e, dopo aver conversato alcune ore con me, ripartirono il giorno stesso.
Dopo una diecina di mesi, ottenni di essere trasferito da Milano a Roma, vicino alla famiglia. In barella fui portato alla stazione, e in una sorta di barella arrivai a Roma, dove fui destinato all’Ospedale instaurato nella villa della regina madre, Margherita di Savoia. La regina occupava il palazzo di via Veneto mentre un edificio della villa a via Boncompagni era stato destinato ai feriti. Ci curava un professore famoso. E dopo due o tre giorni venne a sedersi, accanto al letto, la regina madre, che settimanalmente faceva visita a ogni ferito. Accendeva una conversazione spiritosa, breve, semplice e colta. S’era accorta presto che io amavo lo studio: e m’interrogava gentile. A vederla, vecchia, sì, ma vivace, capivo l’ammirazione di Carducci per lei giovane: Donde venisti? Quali a noi secoli sì mite e bella ti tramandarono? 1.
Un giorno, mi chiese come si chiamasse quel paesino accanto a Tivoli che aveva un nome di giovinetta. – Marcellina! –. Sì, fece lei, Marcellina!, e rise come una bambina. Un altro giorno, le offersi una copia d’una tesina sui Templi di Vesta e della Sibilla, a Tivoli, compilata per l’Università di Roma, dove, dal letto, seguivo i corsi della Facoltà di Lettere e Filosofia; e il 4 ottobre
La rividi qualche anno dopo. Subito, nello scorgermi, osservò: – Lei era quell’ufficiale che studiava sempre.
La sua figura prendeva rilievo dal raffronto con altre dame aristocratiche, le quali talora – di rado – apparivano, contegnose, turrite, arrestandosi sulla soglia della stanza: come una certa principessa imparentata con casa reale, la quale, rigida, mummificata, gittava sguardi di assideramento, convinta che fosse il contegno d’una dama verso i proletari.
Anche a Roma, interventi chirurgici e strazi, compensati da qualche timida visita di mia madre e di mio padre, popolani vestiti modestamente, che con impaccio salivano nella reggia dove regnava il dolore. Venivano anche degli amici.
Dopo circa tre anni, il brano di femore sfarinato dal proiettile era stato rimpiazzato dal così detto callo osseo, che mi consentì di cominciare ad alzarmi e fare qualche passo con le stampelle. In tre anni di letto, avevo preparato tutti gli esami universitari.
Cominciai, in stampelle, ad affrontare l’esame di archeologia cristiana; poi, col bastone, proseguii con le varie materie letterarie, sino alla laurea. Giovandomi d’una licenza accordata ai combattenti, diedi gli esami di letteratura latina e di letteratura greca, improvvisando la versione. Mi toccarono due autori famosi: Tacito e Platone: li tradussi e constatai quanto l’esercizio del seminario mi avesse giovato.
Frattanto, m’ero innamorato di colei che doveva divenire mia moglie, Mya Ora Finiamola Salvati. Il nome, piuttosto bizzarro, le era stato apposto da suo padre, un avvocato, proprietario di terre, che aveva voluto così mettere un limite alla sequela dei figli. Ma il nome non era valso: ché a Mya erano seguiti altri due bambini, in tutto una mezza dozzina.
Gli ultimi due figli avevano frequentato lo stesso mio liceo; ed erano rimasti miei buoni amici. L’amicizia fu accresciuta dai ricordi di guerra.
Igino Giordani, Memorie di un cristiano ingenuo, Città Nuova 1994, pp.55-60