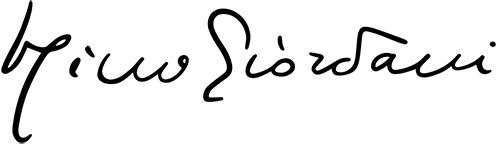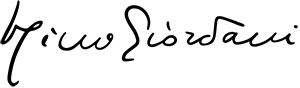Dall’album dei ricordi di Bonizza Giordani
Il 18 aprile ricorre l’anniversario della “partenza per il Cielo” di Igino Giordani. Lo ricordiamo con qualche stralcio di un articolo di Gino Lubich, pubblicato su Città Nuova n.9-10 del maggio 1980.
Il ricordo più lontano, ma chiarissimo, di papà sono le passeggiate. Papà era un grande camminatore, e noi da piccoli facevamo con lui lunghissime passeggiate. Parlo dell’immediato dopoguerra — dice Bonizza —. Abitavamo a via Monte Zebio e si andava per il Lungo Tevere, tutti i giorni. Papà era divertentissimo: camminava sempre con le mani allacciate dietro la schiena e la testa in aria, il viso al vento, col rischio di andare a sbattere… ».
Bonizza era la più piccola dei quattro figli di Igino Giordani, l’unica femminuccia, di salute un po’ fragile, allora.
«Tra me e i miei fratelli Mario, Sergio e Brando c’è un bel po’ di differenza d’età, per cui la mia infanzia è tutta mia, e così il mio rapporto con papà. Speciale. Ero la sua prediletta. Sono vissuta sempre attaccata a papà. Quando i pomeriggi lavorava in casa, nel suo studio, io stavo in ginocchio sulle sue ginocchia e disegnavo; i fratelli intorno scatenavano un chiasso incredibile; nell’altra stanza mamma eseguiva i suoi vocalizzi; lui tranquillo e sereno scriveva e scriveva, un foglietto dopo l’altro, senza mai dirci niente. Tutto sommato il rumore di casa, ritmato dall’eterno solfeggio di mia madre, gli faceva piacere».
Non solo in casa, Giordani riusciva a lavorare nelle condizioni più assurde. In tram, appena si sedeva, scriveva. Se per strada, o in qualsiasi circostanza, anche a un pranzo ufficiale, gli nasceva un’idea, fissava subito un appunto su un pezzettino di carta, o sul retro d’una cartolina, o sul margine d’un giornale, assolutamente estraneo in quei momenti a tutto ciò che gli accadeva attorno. Poi, su quei frammenti, più o meno fortunosamente reperiti in tutte le tasche, ricostruiva il filo lucido d’un articolo o d’un capitolo di libro. «Eh sì — sorride Bonizza —, quello che per il Vaticano e per la Camera era l’ordinatissimo bibliotecario, per me era un simpaticissimo disordinato».
C’era un segreto fra loro due. Si chiamava Caterina. Era un personaggio immaginario, la fantasorellina di Bonizza, che entrava in campo ogni qualvolta minacciava d’incrinarsi la perfetta intesa fra papà e figlioletta. «Caterina, Caterina! — la invocava Giordani —. Vieni qui che c’è Bonizza che mi fa inquietare!»; oppure, se Bonizza non faceva quello che avrebbe dovuto fare: «Non importa — le diceva —, chiamo Caterina». Bonizza sapeva benissimo che Caterina era fantasia, che si trattava d’un gioco, eppure ne era gelosa, era la sua antagonista, divenne la sua coscienza critica.
 Ma più che episodi particolari Bonizza rammenta la preziosità del suo rapporto con quel papà straordinario: «Parlavo moltissimo con lui, in ogni momento del suo tempo libero, e con la massima confidenza, senza alcuna inibizione. Lui sapeva tutto di me. Più che un padre era il mio grande amico. Anche i miei primi amori li ho raccontati a lui, tutti i problemi sentimentali che una ragazzina può avere, e lui li capiva e mi consigliava».
Ma più che episodi particolari Bonizza rammenta la preziosità del suo rapporto con quel papà straordinario: «Parlavo moltissimo con lui, in ogni momento del suo tempo libero, e con la massima confidenza, senza alcuna inibizione. Lui sapeva tutto di me. Più che un padre era il mio grande amico. Anche i miei primi amori li ho raccontati a lui, tutti i problemi sentimentali che una ragazzina può avere, e lui li capiva e mi consigliava».
«Da quando mi ricordo, tutte le mattine papà ha fatto la comunione. Mai un giorno che alle 7 e mezzo precise non uscisse di casa per andare alla chiesa più vicina. A noi ha sempre lasciato la più assoluta libertà, nel massimo rispetto delle nostre scelte, in ogni campo. Anche nella scelta delle nostre attività mai che ci abbia detto o suggerito: fa questo o fai quello. Quand’ero al Cabrini e facevo il IV ginnasio decisi che lo studio classico proprio non mi piaceva. Sognavo l’artistico. Accadde che alla Befana mio padre mi diede 5 o 6 mila lire. Mi parve una somma enorme e la usai per farmi dare qualche lezione da una signorina che dipingeva. Dopodiché andai da papà coi miei disegni: “Questo è quello che so fare io. Vorrei andare al liceo artistico”. In casa fu la tragedia: la mamma che diceva no, tu devi fare il classico come tutti i tuoi fratelli e non lasci una scuola buonissima, con tutte quelle suore che ti voglion bene, per una scuola pubblica a via Ripetta; e i fratelli, per carità, il classico è il classico, poi fai l’università… L’unico a lasciarmi fare e a sostenermi fu papà.
Sognavo l’artistico. Accadde che alla Befana mio padre mi diede 5 o 6 mila lire. Mi parve una somma enorme e la usai per farmi dare qualche lezione da una signorina che dipingeva. Dopodiché andai da papà coi miei disegni: “Questo è quello che so fare io. Vorrei andare al liceo artistico”. In casa fu la tragedia: la mamma che diceva no, tu devi fare il classico come tutti i tuoi fratelli e non lasci una scuola buonissima, con tutte quelle suore che ti voglion bene, per una scuola pubblica a via Ripetta; e i fratelli, per carità, il classico è il classico, poi fai l’università… L’unico a lasciarmi fare e a sostenermi fu papà.
Mi accompagnò al liceo artistico, parlammo col direttore, feci l’esame, fui ammessa. E lì conobbi un sacco di gente, dal poeta Libero de Libero al pittore Purificato, gente di tutte le idee e magari d’ogni stranezza artistica, e tutti conobbero papà e tutti gli divennero amici con grande ammirazione.
Aveva un senso dell’umorismo unico. Ecco, con lui ho sempre avuto un rapporto allegro».
Che non significa idillio, intendiamoci. «Ho partecipato — dice Bonizza — alle sue vicende politiche e culturali, e delle volte non ho approvato certe sue scelte, anche religiose. Alcune mi hanno dato fastidio. Le capisco più adesso, che sono più matura, ma allora ne discutevamo assai, anche in maniera vivace, e lui era contentissimo che gli ponessi quei problemi… No, non siamo stati figli facili, siamo stati figli ribelli, tutti e quattro, dialetticamente terribili intendo, ma mai è venuto meno il nostro grandissimo affiatamento con papà. Ci siamo sempre voluti un bene dell’anima».
«Negli ultimi tempi — ricorda — i discorsi di papà divennero sempre più grandi. L’ultima volta ci parlò di tutto e mi ha rinominato Caterina. Credetti che scherzasse, che rievocasse la mia antagonista immaginaria dell’infanzia. “Papà — gli dissi — chiami Caterina come allora?”. “Quanto sei spiritosa” mormorò, come a dirmi: non capisci. Allora capii, o credetti di capire, che si rivolgeva a santa Caterina. E’ come se mi avesse lanciato un messaggio. Sto rileggendo il suo libro su santa Caterina. Forse è là che ne troverò la chiave».
Gino Lubich